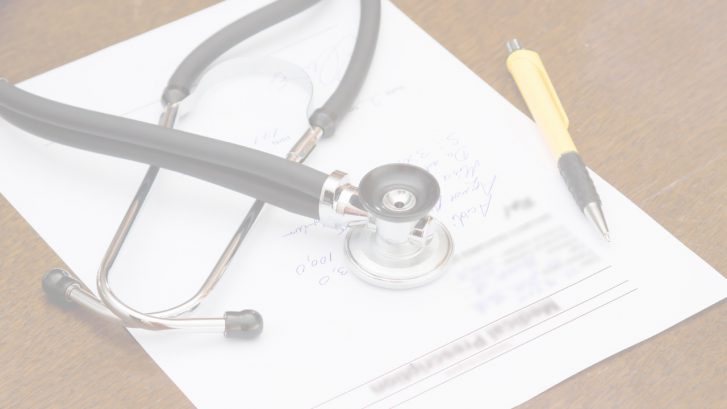
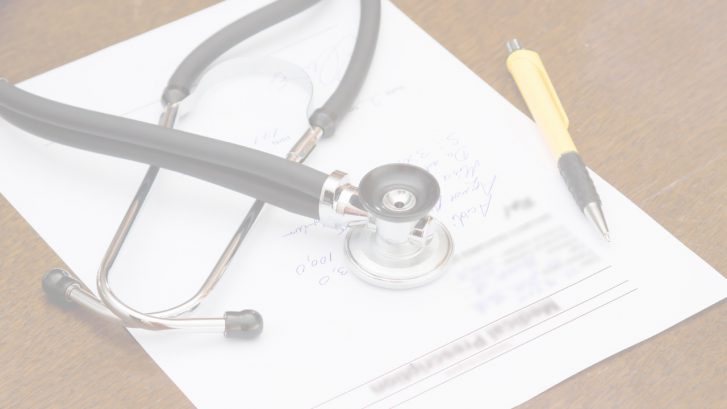
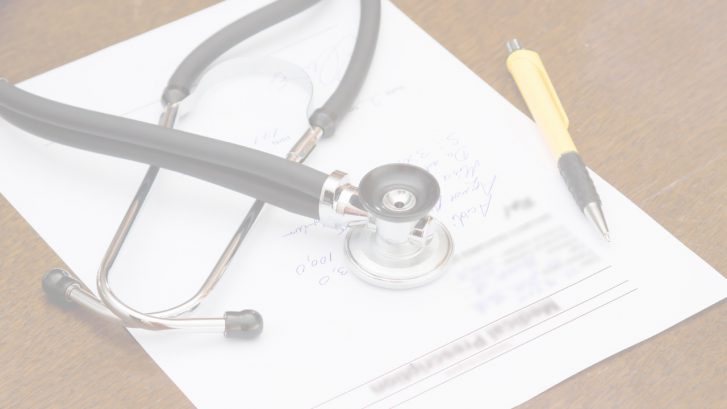
Oms. Ecco la lista dei test diagnostici essenziali
(da Quotidiano Sanità) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato il suo primo ‘Essential Diagnostics List’, un catalogo dei test necessari per diagnosticare le condizioni più comuni e una serie di malattie prioritarie globali. Come l’EML (Essential Medicines List), l’EDL ha lo scopo di fornire una guida basata sull’evidenza e stabilire un riferimento per lo sviluppo o l’aggiornamento degli elenchi nazionali dei test diagnostici in vitro essenziali. Scarica il documento al LINKhttp://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9497904.pdf
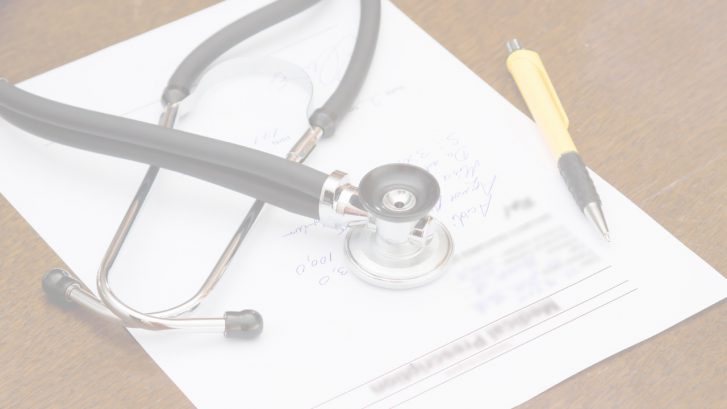
Gravidanza: Il fast food “ostacola” il concepimento
(da Quotidiano Sanità/Nutri&Previeni) Frequentare troppo spesso i fast food, quattro o più volte a settimana, metterebbe a rischio la fertilità della donna. Coloro che mangiano di frequente hamburger e patatine, infatti, impiegherebbero più tempo a restare incinte e avrebbero maggiori probabilità di andare incontro a infertilità, rispetto alle donne che frequentano di rado questi locali. A dimostrarlo è una ricerca pubblicata da ‘Human Reproduction’ e condotta su 5.598 madri tra Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito. Lo studio è stato guidato da Jessica Grieger, del Robinson Research Institute di Adelaide, in Australia.
I dati– Complessivamente, 2.204 donne, ovvero il 39%, sono rimaste incinta entro un mese da quando hanno cominciato a evitare metodi contraccettivi e 468, pari all’8%, non sono riuscite a concepire dopo 12 mesi di tentativi. E mentre le donne che andavano raramente al fast food, o mai, avevano un rischio di infertilità dell’8%, il rischio era del 16% tra coloro che mangiavano in questi locali almeno quattro volte a settimana.
Frutta e verdura– I ricercatori hanno anche considerato il consumo di frutta e hanno visto che le donne che ne consumavano meno di una porzione al mese impiegavano 15 giorni in più per restare incinte rispetto a quelle che mangiavano almeno tre porzioni di frutta al giorno. Con un minore consumo di frutta, insomma, il rischio di infertilità è stato del 12%, rispetto all’8% tra chi consumava più frutta.
I commenti– “I cibi dei fast food contengono elevate quantità di grassi saturi, sodio e a volte zucchero”, dice Grieger. E sebbene “questi componenti non siano stati specificatamente studiati in relazione alla gravidanza umana, quantità elevate di acidi grassi saturi sono stati identificati in ovociti di donne sottoposte a riproduzione assistita e studi su animali da laboratorio hanno evidenziato che una dieta ricca di grassi avrebbe effetti tossici sulle ovaie”. La ricerca, comunque, avrebbe dei limiti, uno su tutti l’affidarsi ai ricordi delle donne, attraverso un questionario, le informazioni su cosa avevano mangiato nel mese precedente il concepimento. “Molti fattori legati allo stile di vita sono associati alla sterilità, come il fumo, il consumo di alcool o l’obesità”, ha sottolineato Joachim Dudenhausen, del Weill Cornell Medicine di New York, che non era coinvolto nello studio. Questa ricerca “offre nuove prove sul ruolo che la dieta può svolgere nell’aiutare il concepimento
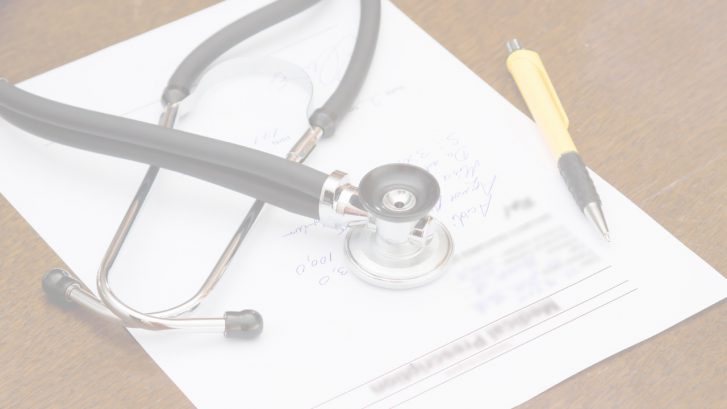
Vaccino contro Hpv, revisione Cochrane dimostra efficacia e sicurezza
(da Doctor33) L’efficacia e la sicurezza del vaccino contro l’Hpv hanno ricevuto in questi giorni una conferma di alta qualità dal punto di vista delle evidenze scientifiche. A sancirla, infatti, è una revisione comparativa indipendente del gruppo Cochrane, che ha esaminato 26 studi condotti complessivamente su oltre 73.000 ragazze e donne. Si è osservato prima di tutto che gli effetti collaterali di una certa rilevanza sono stati rari e simili a quelli riscontrati in coloro che avevano ricevuto un placebo o un altro tipo di vaccino. In ogni caso non si è registrato nessun decesso e neppure eventi avversi gravi, come aborti spontanei o decessi. Sul fronte dell’efficacia della vaccinazione, i ricercatori scrivono che «esistono prove di elevata sicurezza che i vaccini Hpv proteggono dal precancro cervicale ragazze vaccinate tra i 15 ei 26 anni di età».
È l’ennesimo dato a favore di una vaccinazione che aveva già dimostrato la sua validità in diverse ricerche, tanto da ottenere il supporto dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). «In Italia, nei Lea 2018 è prevista tutta una parte relativa alla vaccinazione contro l’Hpv sia per quanto riguarda le ragazze che i ragazzi, – ricorda Carmine Pinto, presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) – abbiamo tutte le condizioni, sia normative che culturali, perché anche nel nostro Paese questo processo possa andare avanti. L’aspetto culturale è in questa fase particolarmente importante, c’è un aumento della consapevolezza che tuttavia deve ancora crescere e su cui bisogna lavorare a livello informativo. Oggi non c’è più bisogno di interventi normativi, nella sanità pubblica si fa molto ma l’azione culturale richiede tempo e non è semplice visto che qui non si parla di malati e a volte è difficile convincere genitori e ragazzi ad aderire ai programmi di vaccinazione». Pinto spiega che i dati sulla copertura vaccinale non sono recentissimi e indicano una grande variabilità tra regione e regione, legata molto all’offerta ma anche alla compliance delle persone giovani a rispondere alla lettera di invito alla vaccinazione. «È comunque indubbio il valore protettivo del vaccino, soprattutto di quello multivalente che è oggi disponibile, – ribadisce il presidente Aiom – non soltanto per prevenire il tumore della cervice dell’utero e della vulva nella donna ma anche per il tumore del pene nell’uomo e, in entrambi i sessi, per il tumore dell’orofaringe».
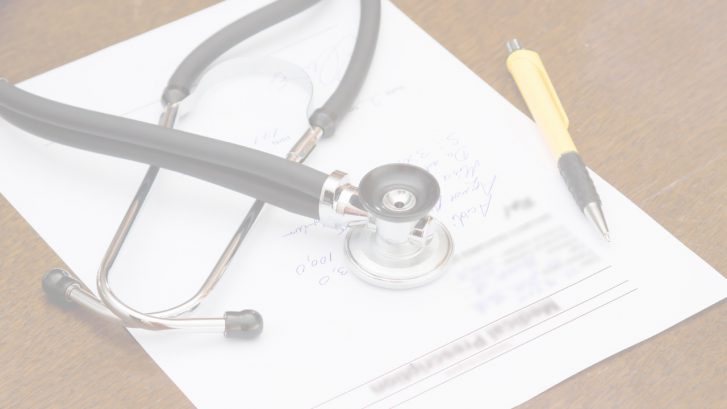
Gli impianti dentali si ‘ammalano’ come denti, entro 2025 boom casi
(da AdnKronos Salute) Anche gli impianti dentali, come i denti, si ‘ammalano’. E nei prossimi anni si stima un forte aumento dei casi in Europa. Lo indica uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Periodontology, condotto all’Università di Pisa da Filippo Graziani, docente al dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’Area critica e presidente eletto della Federazione Europea di parodontologia. “Nel nostro studio abbiamo stimato l’andamento dei casi sia di parodontite, sia di perimplantite, la patologia che colpisce gli impianti dentali”, spiega Graziani. E i risultati indicano che, “da qui al 2025, la parodontite rimarrà stabile nel numero complessivo di casi, mentre la diffusione delle patologie collegate agli impianti dentali crescerà in maniera rilevante, di pari passo con la diffusione dell’implantologia”. La parodontite colpisce 743 milioni di persone nel mondo e rappresenta la sesta malattia cronica più frequente a livello globale. Nella ricerca sono stati interpellati 113 esperti europei sulle previsioni più probabili in ambito parodontale nei prossimi anni. Per condurre l’indagine è stato utilizzato il metodo Delphi, un metodo iterativo che si svolge attraverso più fasi di formulazione e valutazione delle opinioni di un gruppo di esperti su un dato argomento e serve a far emergere una visione completa e condivisa sul tema di interesse. “Livelli elevati di placca, abitudine al fumo e presenza di parodontite sono associate a un rischio maggiore di sviluppare perimplantite – conclude Graziani – Tuttavia questi indicatori possono essere messi sotto controllo prima del trattamento. Infine, se attuato un corretto programma di mantenimento professionale, 3-4 controlli all’anno, si può ridurre l’incidenza della patologia e assicurarne un successo più duraturo”.
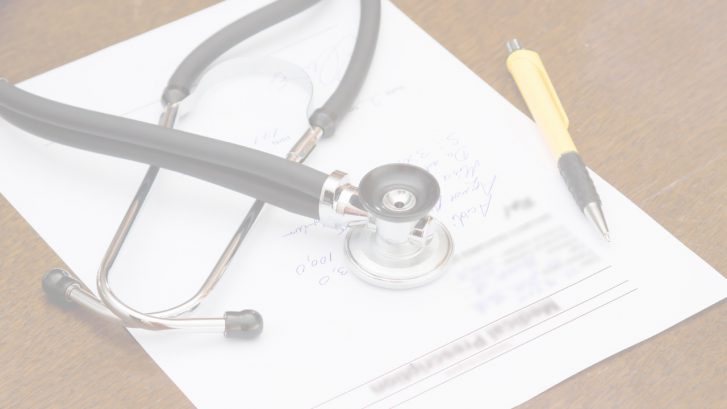
Fnomceo, se a ‘vendere bufale’ è un medico denunciatelo a Ordine
(da (AdnKronos Salute) “Contro le bufale, rivolgetevi ai medici che hanno un percorso di formazione specifico che li rende in grado di disinnescarle. Ma se è proprio un medico a sostenere terapie o indicazioni non fondate scientificamente, segnalatelo all’Ordine professionale”. E’ l’appello di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, che oggi ha presentato a Roma la campagna ‘Una bufala ci seppellirà’, contro le fake news. “Gli Ordini dei medici – ha spiegato Anelli – sono tenuti a vigilare sul fatto che in ogni caso i camici bianchi devono essere aderenti alle evidenze scientifiche. E se è proprio un medico a seminare disinformazione, interveniamo. Negli ultimi anni sono fortemente aumentate le sanzioni comminate dagli ordini, ci sono state anche due o tre radiazioni”. Ma questa, paradossalmente, per Anelli “non è una notizia solo negativa. Vuol dire che la sensibilità dei pazienti e dei cittadini, che spesso segnalano situazioni anomale, è cresciuta”.
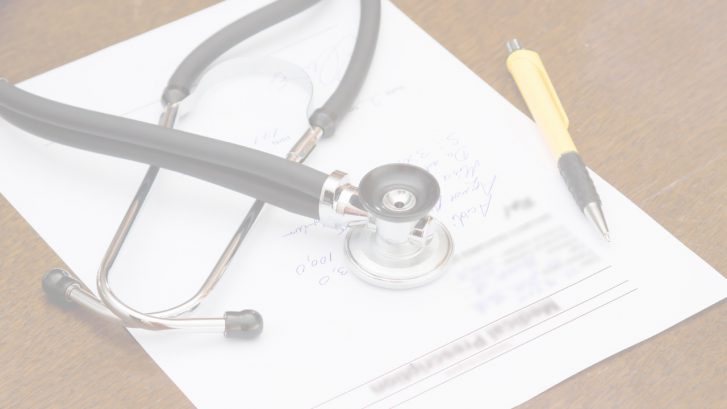
Nuove regole sulla privacy, si profila normativa più semplice per i medici.
(da Doctor33) Niente data protection officer per il medico di famiglia single, e forse niente consenso al trattamento dei dati per il fascicolo sanitario. Si profila una normativa più semplice con il decreto di attuazione del Regolamento europeo, ma il condizionale resta d’obbligo. Entro il 25 maggio solo gli enti sanitari che trattano dati su larga scala devono nominare un DPO, professionista che fa da tramite tra professionisti e aziende titolari di trattamento e adempimenti al regolamento e segnala al Garante eventuali situazioni non in linea. Il decreto di attuazione del regolamento – è la novità che si fa strada – dovrebbe poi abrogare alcune norme strategiche del codice della privacy sul consenso al trattamento dati.
Responsabili protezione dati – Gli ospedali stanno designando i DPO, che possono essere loro dipendenti ma anche reclutati all’esterno con un contratto di servizio, e devono renderli pubblici al Garante che avrà l’elenco dei nuovi profili. Il Garante sta per mettere online una procedura per informarlo delle nomine man mano effettuate, intanto ha prodotto un fac-simile in pdf per “impratichirsi”. Non è obbligato a dotarsi di DPO chi esercita in forma individuale – il medico single -mentre lo sono (dall’articolo 37 del regolamento) coloro che gestiscono dati sanitari su larga scala o la cui attività richiede il monitoraggio sistematico dei soggetti trattati; i medici che gestiscono le cronicità -e in Lombardia sono già in coop – però potrebbero rientrare e, per la verità, il regolamento Ue raccomanda di designare il DPO anche in situazioni dove non c’è uno specifico obbligo.
Gestione del rischio – Di qui al 25 bisogna invece mettersi in regola con il registro dei trattamenti e il Garante ha postato un tutorial (http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/dpia/gestione-del-rischio ) Entro il 21 dovrebbe uscire il decreto di adeguamento con l’ok delle camere per gestire le urgenze, i cui contenuti sono in via di ufficializzazione. Ci si occuperà pure delle nuove regole per il consenso al trattamento dati, che non parrebbe più un “must”. Se inizialmente era previsto come passaggio obbligato ai fini della compilazione del fascicolo sanitario elettronico e del patient summary, ora ci sarebbero forti dubbi, l’Unione Europea sarebbe per uno snellimento degli iter.
Consenso – Il Regolamento Ue abroga gli articoli 76,81,83 e 84 della legge 196/03; per l’articolo 76, i sanitari nell’effettuare prestazioni a tutela della salute di un paziente devono chiedergli il consenso, anche a voce ma in tal caso annotandolo. Fin qui potevano non averlo solo se si tratta di tutelare la salute di terzi o della collettività, ad esempio quarantena in caso di malattia contagiosa o trattamenti obbligatori (da autorizzare dal Garante e dal consiglio superiore di sanità a meno di emergenze obiettive). Inoltre il codice chiedeva al medico che raccoglie il consenso di informare sempre i colleghi in predicato di entrare in contatto con il paziente. Ora il Regolamento suppone che l’ok al trattamento sia implicito nei rapporti di cura implicanti: diagnosi, assistenza o terapia sanitaria; finalità di medicina preventiva e del lavoro; gestione dei sistemi e servizi sanitari e sociali; motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. Altre abrogazioni riguardano l’articolo 83 che vieta di chiamare i pazienti per nome in sala d’attesa, impone agli sportelli d’introdurre distanze tra chi è “sotto” e chi attende, e di evitare che le informazioni sensibili nel colloquio con il sanitario siano ascoltate da terzi. Inoltre, vieta che il paziente riceva visite da parenti che non vuole vedere, e impone il segreto professionale anche agli sportellisti, non tenuti. I Mmg – Paolo Misericordia di NetMedica su FimmgLazio Tv ha sottolineato due cose: il sindacato Fimmg sta per mettere online un software da scaricare con una guida alla compilazione per capire dove si è in regola e dove no e come rimediare, già in rete i requisiti per iscriversi; inoltre, ci sarebbe una disponibilità del Garante di ragionare con la professione sulle procedure per gestire i dati al meglio, «Fimmg potrebbe proporre un documento per condividere modalità operative».

